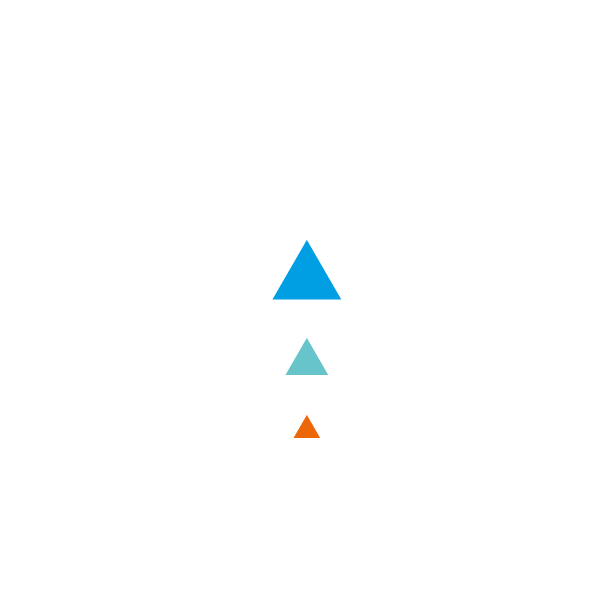In rapporto alla propria identità vi sono due aspetti:
- la ricerca e la espressione intima di essa, che riguarda solamente il soggetto, un rapporto/dialogo io-io e che compone uno scenario composito, completo al suo estremo ma composto da diverse tappe intermedie parziali
- un aspetto sociale, che se da un lato richiama il rimando dell’ambiente della propria immagine “pubblica” ( “esteriore” ), da un altro lato più profondo ed essenziale riguarda il RUOLO che quella entità intima si assume in un determinato spazio e in un determinato tempo che configura la sua realtà/identità storico-ambientale.
Come suggerito nel primo punto, nell’ambito di questi due aspetti occorre distinguere due processi :
- la ricerca di sé in quanto tale
- la ESPRESSIONE di quanto questa ricerca ha portato a conoscere
Per quanto riguarda la ESPRESSIONE della propria realtà intima essa si pone al confine con l’ambito sociale e si confronta direttamente con questo
La ricerca della propria identità intima
Nel considerare questo tema si hanno due termini strettamente connessi :
. ricerca di ciò che mi identifica in quanto individuo, un “me” che costituisce il termine di riferimento delle mie transazioni quotidiane
. ricerca del proprio essere “essenziale” (eventualmente ricerca del proprio Sé), la ricerca e la comprensione della propria Realtà Complessa Interiore, della quale il termine precedente si può intendere come una astrazione
Questi termini si possono intendere come aree in cui la ricerca si svolge.
Ai due termini precedenti ne va poi aggiunto un terzo, il processo di individuazione così come definito da C G Jung che in un certo modo collega i due aspetti precedenti.
Si può dire che la ricerca della propria Identità inizia con una separazione da ciò che siamo stati, dal personaggio che abbiamo incarnato agli occhi degli altri, ma anche e soprattutto di fronte al nostro sguardo nel nostro passato storico.
Il processo di individuazione prevede – ad esempio – in grado variabile una “separazione sociale” che riguarda gli ambiti dei ruoli che ci sono stati assegnati e che abbiamo interiorizzato, delle aspettative a cui si è sottoposti dall’ambiente sociale in cui si è inseriti, della immagine che gli altri ci rimandano e che, spesso, sentiamo di dover sostenere.
In linea di massima cercare una identità autentica significa liberarsi dalle “con-formazioni” sociali, dai modelli che ci rendono simili agli altri ma che così facendo ci allontanano dalla nostra realtà profonda.
La ricerca della propria Identità è allora il ritorno a Casa, un viaggio che percorre l’apparente deserto creato da una graduale distacco dalle figure, dai personaggi, dalle fantasie con cui ci siamo identificati ma che ad un certo punto della nostra vita sentiamo in tutta la sua profondità che non ci appartengono intimamente.
La dimensione intima e intrapsichica della conoscenza di sé riguarda allora la esperienza interiore che il soggetto ha di sé, un dialogo continuo tra le parti della psiche in cui l’identità non si presenta mai come un blocco statico, bensì come una configurazione dinamica, frutto di un percorso progressivo, fatto di tappe, integrazioni e riconciliazioni. Questa dimensione, per sua natura, tende alla totalità, ma la sua realizzazione si manifesta attraverso momenti parziali, simbolici, spesso contraddittori, che solo nel tempo si integrano in un disegno più ampio (Hillman, 1997).
Questa dinamica si esprime come un dialogo intrapsichico costante, un “io che parla a se stesso” (Jung, 2006), nel quale emergono progressivamente aspetti latenti della personalità: immagini, simboli, emozioni e archetipi che compongono una soggettività in continuo movimento.
Incontro con il Sé
Nel percorso di individuazione, il soggetto attraversa una profonda trasformazione interiore che lo conduce verso l’incontro con il Sé, inteso come totalità psichica e centro regolatore della personalità.
Nella sua accezione più ampia, questa non è solo un’opera psicologica: è una traversata dell’anima, un cammino che si fa spirituale.
In questa prospettiva, individuarsi non è soltanto differenziarsi, ma anche riconoscersi come parte di qualcosa di più ampio: una dimensione interiore che trascende l’ego (intrapsichico e sociale) e si apre alla possibilità del Sé, inteso sia come centro psichico sia come nucleo spirituale dell’esistenza.
È un atto di fedeltà a ciò che è più intimo e originario in noi.
Questo spazio del Sé oltre che ad essere il luogo dove non siamo più ciò che gli altri ci chiedono di essere, ma ciò che siamo sempre stati, prima dei nomi, delle ferite, delle aspettative e dei ruoli è il luogo della teofania personale, il luogo della trasfigurazione nella forma di una Realtà Superiore.
Disvelamento
Possiamo impiegare il termine di “disvelamento” (unveiling) (kashf), che è impiegato da Ibn Arabi come processo di conoscenza della Realtà, per indicare un processo analogo che porta alla esperienza della propria Realtà Intima Complessa
La conoscenza di sé, in questa ottica diventa un chiarimento progressivo di una Realtà Interiore Complessa multidimensionale e irriducibile a definizioni strettamente logiche e verbali e che trova piuttosto una sua forma di espressione in un ambiente immaginale e simbolico.
Nel pensiero di Ibn ʿArabī, il termine disvelamento indica un’esperienza conoscitiva diretta e intuitiva della Realtà ultima (al-Ḥaqq), che non avviene per via concettuale ma attraverso un’apertura interiore, un risveglio progressivo della coscienza all’Essere.
Questo stesso processo può essere inteso – in un’ottica integrativa tra psicologia e spiritualità – come il chiarirsi graduale della Realtà Intima Complessa dell’individuo, che è al tempo stesso unica e riflesso del Tutto.
Come nel percorso di individuazione junghiano, anche nel cammino del disvelamento la totalità non si dà tutta insieme, ma attraverso una sequenza di esperienze simboliche, che possono anche sembrare contraddirsi, ma che nella loro tensione dialettica contribuiscono a una visione più ampia e profonda del sé, alla costituzione di una Unirà dai molteplici riflessi, ciascuno descrivente ambiti di realtà e di individualità.
Se poi esaminiamo questo discorso – con la finalità di tracciare connessioni tra una realtà psicologica e una metafisica, processo che a che fare con lo sviluppo di una specifica “vista interiore” – da una prospettiva archetipica, scopriamo come queste immagini dell’anima non puntino a una soluzione definitiva, ma a una molteplicità coesa, una polisemia che è tuttavia ordinata secondo un principio invisibile e operativo.
E questo ci rimanda ancora al tema di quella Realtà Complessa Interiore a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, a cui ci avviciniamo con atto esplorativo che lascia da parte le “definizioni” che all’inizio potevano sembrare la risposte che cercavamo alle nostre domande, ma che si svelano nel processo solo aspetti parziali, a volte fuorvianti.manda ancora al tema di quella Realtà Complessa Interiore a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza.
Il soggetto non “diventa” qualcosa di nuovo, ma ri-conosce ciò che è sempre stato, dietro i veli dell’io costruito nella sua realtà storica contingente e sociale.
Il disvelamento, dunque, è anche un ritorno: una riappropriazione del nucleo originario della propria identità, che si manifesta nel momento in cui non solo si è disposti a lasciar cadere le maschere, le identificazioni parziali, i ruoli e le proiezioni – che si può indicare come una fase prodromica – ma quando la realtà di Sé transtorica si manifesta alla comprensione dell’individuo.
Temi collegati : la Identità sociale – rapporti tra psicoterapia e vie di sviluppo – disvelamento e individuazione – la necessità fondamentale della conoscenza di sé